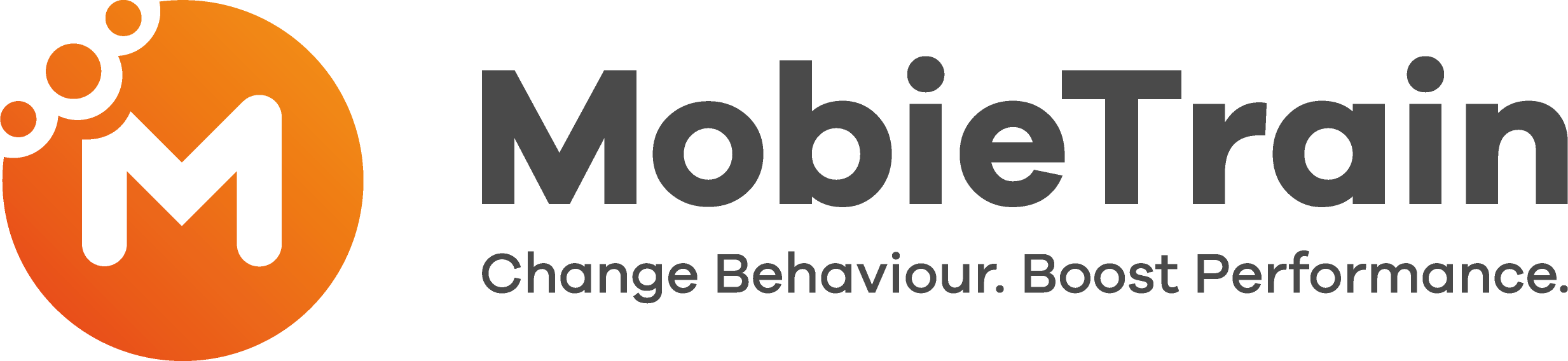Tostapane
Nell’organizzazione moderna della casa, negli anni Trenta, fondamentale è l’elettricità e le sue applicazioni, fornelli, piastre ed il tostapane. Così vi accenna Lidia Morelli nel Nuovo ricettario domestico (Hoepli, 1935):
“Utile è il disporre in casa di un tosta-pane, per avere facilmente del pane arrostito: il più pratico ed elegante è senza dubbio il tosta-pane elettrico”.
La tostatura del pane a cassetta poteva avvenire in forno – vedi: Giovanna, Il pane al pane … (Nistri Lischi, 1931) – ma il nuovo aggeggio facilita tutte le operazioni e nello stesso tempo vincola ad una forma sottile e quadrata del pane. La singola fetta è per la prima colazione, spalmata con la consuetudine o con la fantasia, la doppia è una merenda e più di uno spuntino. Il tostapane prelude, accantonando panini e tramezzini, alla preparazione di toast e per questa ragione, negli anni trenta, i ricettari ritengono l’oggetto di ascendenza britannica, estraneo alla panineria domestica italiana, e non se ne curano. Nel dopoguerra il tostapane “a forma di V rovesciato… a molla o a porte articolate” evolve “verso una scatola quadrangolare con due posti per introdurvi il pane”. “La tostatura simultanea e rapidissima di entrambe le facce di ogni fetta” segna il progresso e il suo inserimento nell’Enciclopedia della famiglia (Mondadori, 1953). Quali sono le ricette? Nessuna, perché se non ve ne sono di stampate, tutti le hanno già stampate nella propria memoria. Ma già l’industria alimentare prepara fette biscottate in sacchetto, i buitost, e il tostapane suonerà desueto.
Il tostapane si diffonde negli anni Trenta con un radicato pregiudizio, di non essere all’origine di un’arte ma di un consumo occasionale, formale il quale non implica ricette ma abitudini. Il panino, se arrivava in tavola doveva avere invece una sua eleganza, essere accreditato e servito, come nella seguente ricetta de Il quattrova illustrato (Domus,1931).